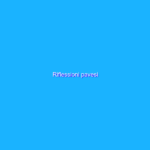Proviamo a riassumere in una sola frase il contenuto di questo libro:
il tempo è maturo perché ogni figura sociale dell’ambiente web tradisca i suoi statuti professionali per salvare la rete da nuovi intermediari e dalla perdita del giornalismo come funzione democratica. Magari non va molto bene, ma dà un’idea di un testo complesso, come complessi erano i nostri pensieri prima di cominciare a scriverlo, e come difficile e intessuta di tante ragioni e fenomeni pensiamo sia la realtà.
I mesi passati tra la concezione del libro, la sua scrittura e la sua pubblicazione ci hanno confermato nelle tesi centrali del libro e hanno aggravato il clima nel quale viene distribuito. Vediamo un paio di esempi.
Il primo: abbiamo scritto mentre un lavoro di investigative reporting chiamava il potere a rispondere di fatti che nel senso comune di tutte le democrazie sono gravi infrazioni dell’etica pubblica[223] . Ci ritroviamo al centro di una guerra civile di veleni in cui si lavora sull’assunto del mitridatismo. Bruciare ogni ghiandola sensibile dell’organismo sociale, far prevalere l’idea che tutti sono sporchi e nessuno ha il diritto di denunciare i vizi degli altri. A essere ottimisti, una buona scuola per le ingenuità dell’opinione pubblica che si esprime in rete, che invece non sembra averne tratto tutte le conseguenze. Il “racconto” non è mai neutro e neutrale, l’informazione è potere, esercizio del potere, anche quando a farla sono un gruppo di cittadini: e se non si capisce qual è il sangue e la merda che ci sono dentro il sistema, si è condannati a non capirne il reale funzionamento.
Il secondo fatto: con la denuncia della Federazione editori giornali contro Google sul caso Google News, e sullo scontro, di livello internazionale, con gli editori di libri è stata annullato quell’effetto di lontananza, di cannocchiale rovesciato, che si prova sempre quando si tratta di cose che avvengono in America. Ora il ruolo che Google ha dentro il business delle nostre aziende riguarda direttamente noi. È tutto sotto i nostri occhi. Si tratta di un ben regolato conflitto sociale che supera la coppia retorica che ha riassunto tutte le questioni di questo genere negli ultimi quindici anni: Google è il cambiamento, chi si oppone è un retrogrado. Oggi abbiamo sul tavolo il caso concreto di una grande azienda, che rappresenta il grande innovatore di questi lustri, ma della quale la società e i soggetti economici desiderano discutere le “male pratiche” davanti a una autorità fornita di un potere sanzionatorio. La carta bollata è sempre odiosa, ma è pur vero che nulla sarebbe accaduto senza l’intervento dell’Antitrust. Vedremo come andrà a finire.
È come se la realtà si fosse incaricata di dimostrare vere, e forse meno visionarie, alcune tesi di questo libro. Noi con ottimismo vediamo in questi avvenimenti il maturare della condizione “politica” presente in questo saggio. In questi mesi – e sarebbe la terza conferma di ciò che abbiamo detto – sono partiti i piani di ristrutturazione all’interno delle grandi aziende giornalistiche e editoriali – e sappiamo sulla nostra pelle di cosa si tratta. Sul mercato stanno arrivando molti professionisti desiderosi di rigenerare e mettere ancora una volta alla prova la propria professionalità dentro il web. Allo stesso tempo, si moltiplicano le iniziative di giornalismo “dal basso” (che brutta dizione), gruppi per lo più di giovani giornalisti che vogliono cominciare a fare sul serio servendosi del web. Le iniziative sono numerose: molte falliranno, qualcuna riuscirà, altre già cercano appoggio e integrazione nel sistema dei media tradizionali.
Troppo poco e forse troppo tardi. Innovazione con il freno a mano nelle aziende editoriali, che per il momento pensano a tagliare e rinviano a un momento successivo la fase di riorganizzazione digitale, che forse alcune di loro pensano proprio di bypassare, ritenendo che il dibattito sui contenuti a pagamento ne abbia mitigato l’urgenza. I nuovi sono timidi, non hanno un percorso di riferimento, e stentano a trovare un modello economicamente valido. I “reduci”, stavamo per scrivere le “vittime” del pogrom generazionale in corso nei giornali italiani, pensano che basti avviare il computer per ritrovare la giovinezza professionale, come se non si trattasse di sposare una mentalità e abitudini professionali abissalmente diverse, come se non si trattasse di cambiare cultura, paese, lingua, di rinnegare madri e padri e affidarsi al nuovo.
Noi abbiamo detto “eresia” perché pensiamo che la rete abbia molto da dare. La rete fragile, coinvolta in questi mesi nella battaglia a tutto campo della politica italiana senza nemmeno capire di che cosa si parli, la rete normata con l’accetta della riduzione al vecchio quadro della responsabilità, come e forse nei peggiori paesi autoritari, la rete, questa larva di libertà economica che ci è rimasta, è ancora il terreno possibile di un grande processo di consapevolezza culturale.
Se sentissimo il bisogno di riepilogarne i punti, significherebbe che questo saggio non funziona, per chi vuole soppesare le tesi una a una c’è l’appendice. Ma i fondamenti dell’eresia sono tutti qui: una rete libera contro la politica normalizzatrice, una cultura che cambia il giornalismo dal di dentro (e crederci ancora dimostra che la fede è davvero temprata nell’acciaio), la rete che fa crescere soggetti nuovi che sparigliano il tavolo e cambiano i termini del discorso. Per il momento l’Italia ha nuovi quotidiani di carta, creature deboli. Ma noi ci speriamo ancora. Rubiamo un buon concetto: «Nulla è più forte di una idea il cui tempo sia venuto»
[224].